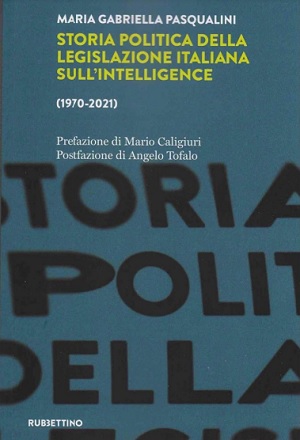- Home
- Ricette Spirituali
- “L’ Injera e il dono della fraternità”: cronaca di un viaggio in Etiopia
“L’ Injera e il dono della fraternità”: cronaca di un viaggio in Etiopia
Nella vita, per diverse ragioni, ho viaggiato tanto. Ho sempre pensato che incontrare persone nuove, confrontarsi con diverse culture, può aprire il cuore e la mente. Come sacerdote poi, ho sempre avuto consapevolezza che il ministero presbiterale è a servizio di tutta la Chiesa e del mondo intero. Non può essere circoscritto o sacrificato in un gruppo o una piccola comunità autoreferenziale. Dopo una notte praticamente insonne, arrivai ad Addis Abbeba, una metropoli oramai con più di 4 milioni di abitanti, situata nel cuore dell’Etiopia.
La macchina del buon P. Marcello, missionario da moltissimi anni, era ben solida e ci permetteva di  viaggiare tranquilli. Dal finestrino dell’auto osservavo la gente che camminava tranquillamente nelle vie: tante persone che andavano e venivano, un flusso ininterrotto di contadini, impiegati, donne e bambini che con passo rapido e regolare si affrettavano verso i mercati della zona, i luoghi di lavoro e le scuole. Dopo molte ore di cammino giungemmo a visitare la Scuola. All’ingresso della missione ci accolsero, festosi, moltissimi bambini e ragazzi cantando ed esultando di gioia. Un bambino cieco parlò a nome di tutti. Le sue parole chiare e profonde colpirono molto: “vi ringraziamo perché grazie a voi abbiamo una scuola e siamo felici di poter studiare insieme. Qui apprendiamo a vivere e ci sentiamo uguali agli altri con le stesse possibilità e gli stessi sentimenti, siamo felici grazie a voi, perché abbiamo tutti una nuova dignità, esattamente come tutti gli altri”.
viaggiare tranquilli. Dal finestrino dell’auto osservavo la gente che camminava tranquillamente nelle vie: tante persone che andavano e venivano, un flusso ininterrotto di contadini, impiegati, donne e bambini che con passo rapido e regolare si affrettavano verso i mercati della zona, i luoghi di lavoro e le scuole. Dopo molte ore di cammino giungemmo a visitare la Scuola. All’ingresso della missione ci accolsero, festosi, moltissimi bambini e ragazzi cantando ed esultando di gioia. Un bambino cieco parlò a nome di tutti. Le sue parole chiare e profonde colpirono molto: “vi ringraziamo perché grazie a voi abbiamo una scuola e siamo felici di poter studiare insieme. Qui apprendiamo a vivere e ci sentiamo uguali agli altri con le stesse possibilità e gli stessi sentimenti, siamo felici grazie a voi, perché abbiamo tutti una nuova dignità, esattamente come tutti gli altri”.
La lunga giornata si concluse con una bella iniziativa organizzata da “Il villaggio dei ragazzi sorridenti”, il centro di accoglienza per bambini di strada di P. Marcello. Quella sera, per la prima volta nella mia vita, mangiai una sorta di pane particolare l’Injera. Per gli etiopici l’ospitalità è sacra e declinare l’invito sarebbe stato alquanto indelicato.
I problemi per me iniziarono quando un ragazzo mi portò un piatto fumante, in alluminio, simile a quelli che usavano i militari durante la guerra. Dal piatto si intravedeva una non ben definita massa informe di colore grigiastro, piuttosto spugnosa e oscillante come una gelatina che non sapevo cosa fosse.
che usavano i militari durante la guerra. Dal piatto si intravedeva una non ben definita massa informe di colore grigiastro, piuttosto spugnosa e oscillante come una gelatina che non sapevo cosa fosse.
Appariva come una sorta di avanzo alimentare e confesso che mi faceva un po’ ripugnanza. Ma, a me piace sperimentare nuovi gusti e conoscere nuove culture anche attraverso i sapori, pertanto, senza scoraggiarmi, per togliermi ogni dubbio, addentai il primo boccone e al contrario dell’impressione iniziale, devo ammettere che rimasi piacevolmente sorpreso perché, nonostante la novità del gusto piuttosto acidulo, quell’alimento strano, mi piaceva molto: un odore ed un sapore unici che mi conquistarono così tanto da fare il bis.
Mi chiedevo cosa fosse e mi risposero si trattava di un piatto tipico della cucina etiopica ed eritrea: l’Injera (in ge’ez: እንጀራ, ənǧära). La pietanza viene preparata con la farina di Teff, un cereale originario degli altopiani etiopici. Il Teff contiene alcuni batteri fermentativi che causano il processo di fermentazione e lievitazione della farina stessa. Questo cereale, comunemente coltivato in Etiopia, è molto usato anche in Eritrea, Somalia, Yemen e presso il popolo Nuer del Sudan. Per i loro abitanti rappresenta quello che il frumento è per gli europei e il riso per asiatici, cioè la base dell’alimentazione.
Il giovane che l’aveva servito ad una mia richiesta circa la natura di quel cibo, mi disse che quella farina mescolata con l’acqua veniva lavorata fino ad ottenere un impasto cremoso che poi veniva lasciato fermentare almeno 24 ore per 3/4 giorni, a seconda dei gusti; invece per la cottura doveva essere versato e spalmato su larghe piastre di metallo molto calde e chiuse da un coperchio (queste vettovaglie si chiamano i mogogo).
chiamano i mogogo).
In pochi minuti di cottura si poteva ottenere, più che un pane, una sorta di crepe morbida, umida, porosa, di colore grigiastro, con numerose bollicine e un sapore leggermente acidulo, dovuto alla fermentazione. Dentro la crepe si può mettere quel che si vuole ma generalmente si associa alla carne (dorowot, segawot) o alle verdure e salse molto piccanti. Allo spezzatino di carne vien aggiunta molta cipolla e molte spezie che formano il cosidetto Zighini.
L’injera per essere gustata bene deve necessariamente essere accompagnata da questi cibi e lo Zighini a sua volta non può essere preparato senza il berberè una sorta di salsa aromatizzata. Il berberè è un’antica e tradizionale miscela di spezie tipicamente africana con un profumo intenso e immediatamente riconoscibile.
Quando chiesi informazioni circa gli ingredienti di questa salsa mi dissero che era una miscellanea ben  dosata di peperoncino, cumino, cannella, curcuma, zenzero, pepe nero, pepe lungo, coriandolo, chiodi di garofano, ruta, fieno greco, cardamomo ecc. A me pareva una miscela esplosiva, cosi piccante da non riuscire a mandarla giù. Ma indubbiamente il profumo e il sapore complessivo della pietanza erano molto invitanti, tanto che, dopo essermi abituato alla novità, ne mangiai diverse porzioni anche nei giorni successivi.
dosata di peperoncino, cumino, cannella, curcuma, zenzero, pepe nero, pepe lungo, coriandolo, chiodi di garofano, ruta, fieno greco, cardamomo ecc. A me pareva una miscela esplosiva, cosi piccante da non riuscire a mandarla giù. Ma indubbiamente il profumo e il sapore complessivo della pietanza erano molto invitanti, tanto che, dopo essermi abituato alla novità, ne mangiai diverse porzioni anche nei giorni successivi.
L’injera, una volta farcita, viene servita a rotoli così da essere facilmente manducata; la tradizione vuole che gli stessi pezzi di injera servano a raccogliere il cibo, ovviamente con le mani. Quando ragazzi e missionari, alcuni seduti per terra, altri accomodati su piccoli sgabelli ebbero mangiato l’injera, capii che quello era decisamente un rituale importante e che la fraternità, in quella cultura si consolidava proprio con quel pasto comunitario.
Avevo anche compreso che un pasto etiope non poteva dirsi concluso senza il rito del caffè, il cui nome - caffè - deriverebbe proprio dalla provincia etiopica di Kaffa. A proposito di caffè bisogna ricordare che da sempre i chicchi di questa favolosa pianta costituiscono uno dei cardini dell’economia del paese. Non si  sa con precisione ma quello che è certo che le prime piante del caffè vennero scoperte intorno al IX sec. a Kaffa, regione etiopica. Mi piace qui descrivere la solennità del momento vissuto con quella comunità perché si discosta grandemente dal nostro modo frettoloso di prendere il caffè a fine pasto.
sa con precisione ma quello che è certo che le prime piante del caffè vennero scoperte intorno al IX sec. a Kaffa, regione etiopica. Mi piace qui descrivere la solennità del momento vissuto con quella comunità perché si discosta grandemente dal nostro modo frettoloso di prendere il caffè a fine pasto.
Il rito del caffè prevede un vero e proprio cerimoniale: una donna - in generale una delle donne della casa o la più anziana -, prima di servire il caffè si mise a spargere dell’erba fresca in un angolo della stanza, - questa scena l’ho vista persino nelle hall degli alberghi - per portare, all’interno della casa, un po’ della fragranza e della freschezza della natura. Dopodiché si sedette su uno sgabello basso vicino ad un braciere con del carbone ardente dove vi mise dell’’incenso profumato. Versò dei chicchi verdi di caffè in una padella agitandoli per farli tostare uniformemente. Una volta tostati i chicchi, la donna si alzò con eleganza e passò davanti a tutti con la scodella in mano scuotendola in modo che tutti potessimo sentire la fragranza del caffè tostato. Dopo questo gesto scomparve: mi dissero che era andata in luogo a parte a polverizzare i chicchi con pestello e mortaio. La donna riapparve con la tradizionale brocca di argilla tonda e rigonfia alla base, con un lungo collo laterale che termina con un beccuccio (il filtro, sul beccuccio, mi avevano detto che era di crine di cavallo). Riscaldata l'acqua della brocca, vi aggiunse il caffè e lo fece bollire. Versò il caffè, caldissimo, in tazzine senza manico nelle quali aggiungeva dello zucchero e - a discrezione - un ramoscello di ruta. Mi piacque molto quel caffè, ben diverso dal nostro molto più corposo e per niente amaro, forte e scuro, fruttato e con un retrogusto strano che sapeva di affumicato.
Sul fondo della tazza rimaneva una posa compatta e cremosa. Quando tutti ebbero bevuto, quella donna raccolse le tazze di tutti e aggiunse altra acqua per preparare un secondo giro, usando gli stessi chicchi. Mi avevano spiegato che faceva parte della tradizione fare tre giri e che il primo giro si chiama Awel in tigrino, il secondo Kole’i e il terzo bereke (benedetto), ma io mi limitai soltanto al secondo giro. Il missionario che era con me aggiunse che in Etiopia dicono che il primo giro, più forte, è per i padri, il secondo per le madri e il terzo, il più debole, per i piccoli.
raccolse le tazze di tutti e aggiunse altra acqua per preparare un secondo giro, usando gli stessi chicchi. Mi avevano spiegato che faceva parte della tradizione fare tre giri e che il primo giro si chiama Awel in tigrino, il secondo Kole’i e il terzo bereke (benedetto), ma io mi limitai soltanto al secondo giro. Il missionario che era con me aggiunse che in Etiopia dicono che il primo giro, più forte, è per i padri, il secondo per le madri e il terzo, il più debole, per i piccoli.
Mentre prendevo il mio lume e andavo nella mia camera, al termine dell’intensissima ed emozionantissima giornata, pensavo: “tutto quello che ho visto è un miracolo”! E’ tutto merito della Divina Provvidenza e di tanti che generosamente danno il proprio contributo per questo progetto. Certo! Ma se non vi fosse stato un Zebegna – cioè una guida attenta, premurosa e vigile, come P. Marcello non sarebbe accaduto nulla. Ecco perché ognuno di noi è indispensabile agli altri. Ognuno di noi è un dono di Dio per l’altro e la fraternità vissuta attorno alla tavola – il dono del pasto - aveva effettivamente suggellato questa verità cristiana.
Del resto il Signore è proprio durante una Cena che ci ha donato tutto sè stesso.
Don Alfonso GIORGIO




Ultimi Video
-
L'ultima notte...esistenze al capolinea
L' ultima notte...esistenze al capolinea. Intervengono al convegno organizzato da L'Albero Verde della Vita - associazione socio-culturale di promozione ... -
Merry Christmas and happy New Year
L'Albero Verde della Vita e La Linfa Vi augurano un Buon Natale ed un Sereno Anno Nuovo. ... -
Il giardino delle delizie: tradizioni e folklore alimentare dell'Apulia Italica
'I Sapori del Grano - VI° edizione' - Gravina in Puglia, 14 settembre 2024: manifestazione internazionale organizzata da ... -
Grana dat et vina: Una sana tradizione alimentare millenaria
'I Sapori del Grano - VI° edizione' - Gravina in Puglia, 13 settembre 2024: manifestazione internazionale organizzata da ... -
La Lunga Notte delle Chiese - I° edizione - venerdì 7 giugno 2024 - Gioia del Colle (BA)
La Lunga Notte delle Chiese - I° edizione - venerdì 7 giugno 2024 - Gioia del Colle (BA): ... -
Rettoria di San Domenico: concerto, Ensemble di violini della scuola media “Bosco-Venisti”
Rettoria di San Domenico: concerto, Ensemble di violini della scuola media “Bosco-Venisti” di Capurso diretti dal prof. Francesco LAMANNA. ... -
Rettoria di Sant’Angelo - La Lunga Notte delle Chiese - I° edizione
Rettoria di Sant’Angelo: visita guidata alla scoperta del Santo Patrono gioiese SAN FILIPPO NERI ... -
Parrocchia Santa Maria Maggiore (Chiesa Madre) - La Lunga Notte delle Chiese - I° edizione
Parrocchia di Santa Maria Maggiore: Santa Messa concelebrata da don Angelo GAROFALO, Vicario Episcopale per la Cultura della ... -
Rettoria di San Rocco - La Lunga Notte delle Chiese - I° edizione -
Rettoria di San Rocco: convegno intitolato “Le sfide comuni tra le confessioni religiose” Interventi: Prof.ssa Sabrina Laura MARTUCCI, ... -
Parrocchia del Sacro Cuore - La Lunga Notte delle Chiese - I° edizione -
Parrocchia del Sacro Cuore: momento di gioiosa esperienza di fede comunitaria animata dal RnS – Rinnovamento nello Spirito ... -
Parrocchia di San Vito Martire - La Lunga Notte delle Chiese - I° edizione -
Parrocchia di San Vito Martire: momento di intrattenimento musicale con il cantante Said SADEK, l’angolo del tè nella ... -
What if green?
Cosa succederebbe se tutto fosse e dovesse essere verde? L'Albero Verde della Vita affronta l’ipotetico dialogo tra lo ... -
L'Assordante Rumore del Silenzio: storie di ordinaria violenza
Evento organizzato dall'associazione socio culturale di promozione sociale - Ente del Terzo Settore - L'Albero Verde della Vita: sala ... -
L'Assordante Rumore del Silenzio
"L'Assordante Rumore del Silenzio, venerdì 8 marzo 2024, Senato della Repubblica". ... -
MOSSAD: Commissione d'Inchiesta
Un romanzo avvincente che mescola realtà storica dei fatti con immaginazione ... -
MOSSAD: Commissione d'Inchiesta
Definito “un romanzo avvincente che mescola realtà storica dei fatti con immaginazione”, Mossad - Commissione d'Inchiesta, descrive una serie di ... -
Crea il tuo momento e rendilo giusto....
con L'Albero Verde della Vita, puoi! ... -
BUON NATALE E FELICE ANNO NUOVO
L'Albero Verde della Vita - associazione socio culturale di promozione sociale - Ente del Terzo Settore e La ... -
L'ora del Giudizio: Israele, Hamas, Hezbollah
... -
Israele, Hamas, Hezbollah: l’ora del giudizio
L’Albero Verde della Vita - associazione socio culturale di promozione sociale – Ente del Terzo Settore ed il giornalista, scrittore di successo ... -
Disinformazione in un tempo di forte emergenza democratica e educativa
Operazioni psicologiche e guerre dell'informazione ... -
Disinformazione: operazioni psicologiche e guerre dell'informazione
La guerra delle bugie nella società della disinformazione. Avventure e disavventure della verità L’Albero Verde della Vita - associazione socio culturale ... -
Perchè la Rete?
... -
La Rete: l'Intelligence tra realtà e immaginazione
L’Albero Verde della Vita - associazione socio culturale di promozione sociale – Ente del Terzo Settore ed il dott. Umberto Saccone, già Capo ... -
Spie
... -
Spie: i Servizi Segreti delle multinazionali..
“Come si combatte la guerra che vede ogni giorno schierate le multinazionali nel tentativo di imporsi su nuovi ... -
OLTRE LE BARRIERE
Oltre le Barriere, è un progetto di inclusione socio-culturale che mira ad abbattere le disugluaglianze sociali e di genere, valorizzando, con ... -
NOI CON VOI, VOI CON NOI
NOI CON VOI, VOI CON NOI. Aderisci alla campagna di iscrizione a L'Albero Verde della Vita. Potrai partecipare ... -
San Martino: festa della mozzarella e del buon vino - 8^ edizione
... -
San Martino, festa della mozzarella e del buon vino - 8° edizione
L'8° edizione de "San Martino, festa della mozzarella e del buon vino" sta arrivando: sabato 25 novembre 2023 ... -
Misteri e Segreti Italiani: la versione di Pazienza
Il racconto inedito dell'ex agente del Sismi protagonista di tanti misteri italiani. “Misteri e Segreti Italiani: la versione di Pazienza” ne ... -
La Spiga d'oro: colture della salute ed alimentazione sociale
"I Sapori del Grano - V° edizione" - sabato 23.09.2023 - attività convegnistica organizzata dall'associazione L'Albero Verde della ... -
"Pane, vino ed olio: i cibi sacri della cultura greco-romana"
"Storia e folklore della popolazione italica": attività convegnistica organizzata da L'Albero Verde della Vita - APS - Ente ... -
I Sapori del Grano - V° edizione: grazie Santeramo
... -
I Sapori del Grano - V° edizione
Tutto pronto per la V° edizione de "I Sapori del Grano" manifestazione organizzata da L'Albero Verde della Vita ... -
"I Sapori del Grano" - IV° edizione
In attesa della V edizione de "I Sapori del Grano" venerdì 22, sabato 23 e domenica 24 settembre ... -
I SUCCESSI DEL 2021 DE L'ALBERO VERDE DELLA VITA
I momenti più belli condivisi con L'Albero Verde della Vita nell'anno 2021 ... -
Intelligence Collettiva: Appunti di un ingegnere rapito dai Servizi Segreti
Prosegue lunedì 12 giugno 2023 la maratona nel mondo dell’intelligence con l’On. Angelo TOFALO nel secondo webinar dal titolo “Intelligence Collettiva: Appunti di ... -
Intelligence Collettiva: appunti di un ingegnere rapito dai Servizi Segreti
Prosegue lunedì 12 giugno 2023 la maratona nel mondo dell’intelligence con l’On. Angelo TOFALO nel secondo webinar dal ... -
...dalle origini ai giorni nostri...
La Cultura dell'Intelligence ... -
La cultura dell'Intelligence: dalle origini ai giorni nostri
Mercoledì 24 maggio 2023 alle ore 19.30 con L’Albero Verde della Vita, associazione socio culturale di promozione sociale – ... -
...pensa in verde e cambi il mondo...
...pensa in verde e cambi il mondo..."Transizione verde: una sfida anche culturale per imprese competitive e cittadini consapevoli". ... -
Thinking green, changing world
Mai così attuale e divisivo il tema del cambiamento climatico, della transizione ecologica, degli interventi strutturali non attuati ... -
I chiaroscuri di un'Umanità rigenerata dalla Luce I° Parte
L’Albero Verde della Vita, associazione socio culturale di promozione sociale – Ente del terzo Settore, vi invita, lunedì 3 aprile 2023, alle ore 19.30, ... -
I chiaroscuri di un'Umanità rigenerata dalla Luce 2° Parte
L'Albero Verde della Vita, associazione socio culturale di promozione sociale - Ente del Terzo Settore -, conclude il ... -
L'importante non è ciò che facciamo....2020
Gli eventi del 2020 de L'Albero Verde della Vita ... -
Gli eventi del 2019 de L'Albero Verde della Vita
Gli eventi che hanno caratterizzato l'anno 2019 de L'Albero Verde della Vita. ... -
I Sapori del Grano, 19-20 settembre 2020
“I Sapori del Grano – II edizione”, una manifestazione d’interscambio culturale a carattere internazionale e diffusione nazionale, accreditata ...
Vedi tutti i video »
Clicca sul Banner in basso e guarda il video
Inquadra il codice qr e sostienici!
Oltre le barriere - 2k24 -
è un progetto de
L'Albero Verde della Vita
_____________________________
_______________________
DOMUS SAPIENTIAE - Collana Testi

(Liber I)
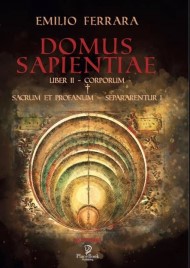
(Liber II)
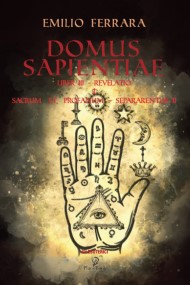
______________________